Da matematico e appassionato di scienza mi son sempre chiesto perché le grandi intuizioni scientifiche dei pensatori greci siano cadute in un letargo lungo duemila anni, prima di essere ridestate nel Rinascimento e portate avanti nei secoli successivi fino all’epoca moderna.
Più o meno tutti gli intellettuali sono concordi nel ritenere il sesto secolo avanti Cristo come un momento storico irripetibile del sapere umano, periodo in cui si registra una magica coincidenza temporale tra gli insegnamenti spirituali di Buddha, Lao Tze, Confucio in Estremo Oriente, e il movimento culturale che si sviluppò in Occidente coi presocratici. Questi ultimi, uomini dalle capacità visionarie quasi mistiche, vivevano in regioni affacciate sul mare e protette da una costa rocciosa, frastagliata e scoscesa. E’ qui, in queste terre baciate dal profumo e dal colore del mare nostrum, che nasce il primo metodo scientifico dell’umanità, basato su quello spirito d’indagine ereditato duemila anni dopo dagli scienziati moderni. Nella Grecia di quegli anni, priva dell’influenza di un grande stato di un potente impero, c’erano tutte le condizioni favorevoli allo sviluppo di un pensiero libero. Allo stesso tempo non esisteva, come per esempio in Babilonia e in Egitto, una forte casta sacerdotale ereditaria e privilegiata che, anche se non governava direttamente, di solito si opponeva allo sviluppo di nuove idee. Nelle piccole e indipendenti città greche si parla per la prima volta della polis, luogo dove la maggior parte delle persone, che sanno leggere e scrivere, discute di come strutturare il potere e in che modo prendere decisioni importanti in un processo altamente democratico. Fu così che in quei microcosmi di politica democratica, dove era naturale concepire l’idea che le decisioni migliori possano emergere solo da una discussione critica fra tanti uguali invece che dall’autorità di uno solo, che vennero poste le fondamenta della futura ricerca scientifica del sapere.
Il segreto dei grandi pensatori greci fu di intuire che il mondo potesse essere compreso da chi si desse la pena di osservarlo appropriatamente; e soprattutto, che esso non fosse la scena delle azioni più o meno volontarie degli dèi in preda a impulsi, soggetti alle passioni, all’ira, all’amore e al desiderio di vendetta. I pensatori greci seppero liberarsi da ogni superstizione e, assieme alla loro immaginazione ragionata, superarono i limiti dei pregiudizi. Le loro intuizioni regalarono all’umanità idee audaci e meravigliose, che possiamo paragonare ad atti creativi di straordinaria libertà di pensiero, animate com’erano da quella pura curiosità conoscitiva capace di provare meraviglia per il mistero nascosto dietro ogni ricerca.
“La storia dell’antica filosofia greca – dice Karl Popper – specialmente da Talete a Platone, è splendida. Troppo splendida per essere vera. In ognuna di queste generazioni troviamo perlomeno una nuova filosofia, una nuova cosmologia di sorprendente originalità e profondità. Come fu possibile ciò? Certamente, l’originalità e il genio sono insondabili. Ma si può tentare di gettarvi un po’ di luce. Quale era il segreto degli antichi? Ritengo che fosse una tradizione, una tradizione della discussione critica.”
La teoria di Anassimandro per esempio, che la Terra non è sostenuta da nulla ma rimane ferma in ragione del fatto che è equidistante da tutte le altre cose, è secondo lo stesso Popper una delle idee più audaci, rivoluzionarie e prodigiose rappresentazioni di tutta la storia del pensiero umano. E’ da qui che prende l’avvio l’eliocentrismo di Aristarco, trecento anni dopo Anassimandro, e di Copernico, mille e ottocento anni dopo Aristarco. Considerare la Terra liberamente in equilibrio in mezzo allo spazio semplicemente perché, secondo Anassimandro, non aveva una direzione particolare verso la quale cadere, significò anticipare la concezione di Newton delle forze gravitazionali, immateriali e invisibili. Anassimandro arrivò a questa teoria non certo mediante l’osservazione, bensì con il puro ragionamento. Egli concepì l’idea di una simmetria interna o strutturale del mondo, la quale escludeva l’esisitenza di una direzione privilegiata nella quale possa verificarsi una caduta. Con ciò si attenne al principio, anticipando di fatto le leggi di conservazione della fisica moderna, che laddove non esistono differenze non vi può essere mutamento alcuno. La sua teoria sulla stabilità della Terra, mediante l’uguaglianza delle distanze che la separano da tutte le altre realtà, eliminò l’idea di una direzione assoluta verso l’alto o verso il basso. In definitiva è solo sulla Terra che esiste la direzione assoluta per gli oggetti che cadono, poiché costretti a seguire una forza attrattiva verso il basso (quella che diventerà duemila e duecento anni dopo la forza di gravità).
La magia dell’illuminismo greco non durerà a lungo. Pochi secoli dopo l’impero romano riporterà il potere nelle mani di un singolo e il cristianesimo riporterà il sapere nelle mani del divino. La grande biblioteca di Alessandria, depositaria del sapere antico, è bruciata e devastata dai cristiani, mentre i pagani asseragliati nel grande tempio di Apollo vengono trucidati.

“Il dio del monoteismo – osserva il fisico Carlo Rovelli – è un dio geloso, che più di una volta nei secoli ha attaccato e distrutto con violenza cieca tutto ciò che gli si è ribellato. Il risultato della violenza antintellettuale dell’impero romano cristianizzato sarà di soffocare quasi ogni sviluppo del sapere razionale per molti secoli a seguire. Con la conquista dell’impero da parte del cristianesimo, l’antica struttura teocratica e assolutistica dei grandi imperi antichi è così restaurata, ora su scala assai più ampia, e la parentesi di luce e di pensiero libero accesasi in Grecia nel sesto secolo avanti Cristo si è richiusa. Le tracce dell’antico pensiero, cresciuto a partire dall’audacia intellettuale di Anassimandro, resteranno sepolte in pochi codici antichi sopravvissuti alla furia dei primi cristiani al potere, studiate e tramandate con quasi riverente timore da pochi sapienti indiani, poi persiani e arabi. Ma nessuno fino a Copernico saprà più comprendere e far propria la lezione di Anassimandro.”
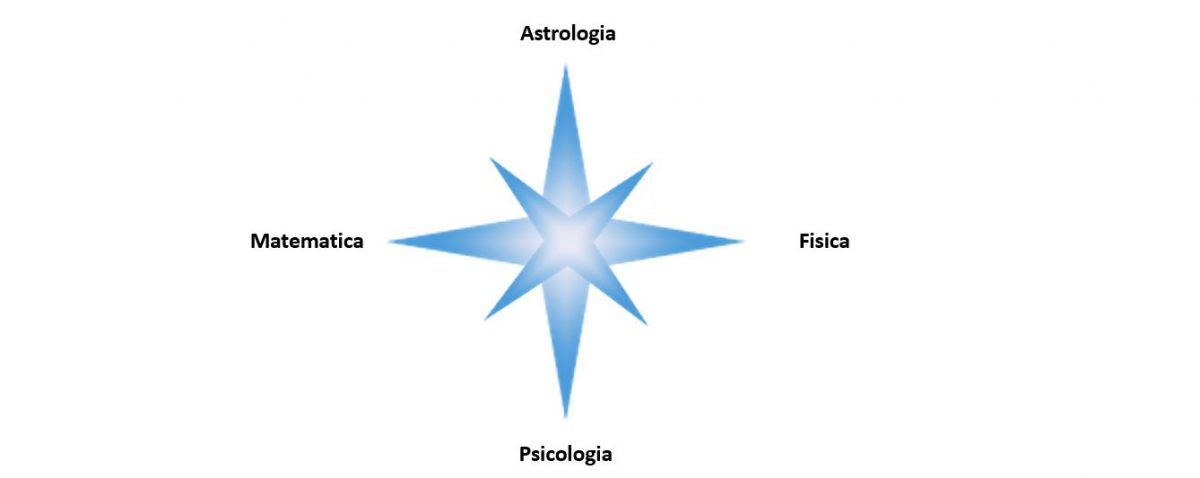
 Uno degli esempi più illustri di parricidio artistico è quello di Pablo Picasso. “En arte hay que matar el padre” confidò il pittore andaluso ad un amico quando, nell’autoritratto Yo Picasso del 1901, decise di sostituire definitivamente il cognome paterno con quello della madre. Il padre, don José Ruiz, era un modesto pittore specializzato in quadri da soggiorno in cui i piccioni apparivano come soggetto prevalente. Era anche professore alla scuola di Belle Arti a Barcellona, qualifica che mascherava un fallimento artistico messo ancor più in evidenza dal talento smisurato del figlio. Non deve pertanto stupire l’abbandono della prestigiosa Accademia Reale di Madrid, nella quale Pablo venne iscritto con l’ausilio finanziario dello zio don Salvador Ruiz, medico di Malaga e orgoglioso di dare lustro a quel cognome di famiglia che solo qualche anno dopo il nipote avrebbe rinnegato.
Uno degli esempi più illustri di parricidio artistico è quello di Pablo Picasso. “En arte hay que matar el padre” confidò il pittore andaluso ad un amico quando, nell’autoritratto Yo Picasso del 1901, decise di sostituire definitivamente il cognome paterno con quello della madre. Il padre, don José Ruiz, era un modesto pittore specializzato in quadri da soggiorno in cui i piccioni apparivano come soggetto prevalente. Era anche professore alla scuola di Belle Arti a Barcellona, qualifica che mascherava un fallimento artistico messo ancor più in evidenza dal talento smisurato del figlio. Non deve pertanto stupire l’abbandono della prestigiosa Accademia Reale di Madrid, nella quale Pablo venne iscritto con l’ausilio finanziario dello zio don Salvador Ruiz, medico di Malaga e orgoglioso di dare lustro a quel cognome di famiglia che solo qualche anno dopo il nipote avrebbe rinnegato.