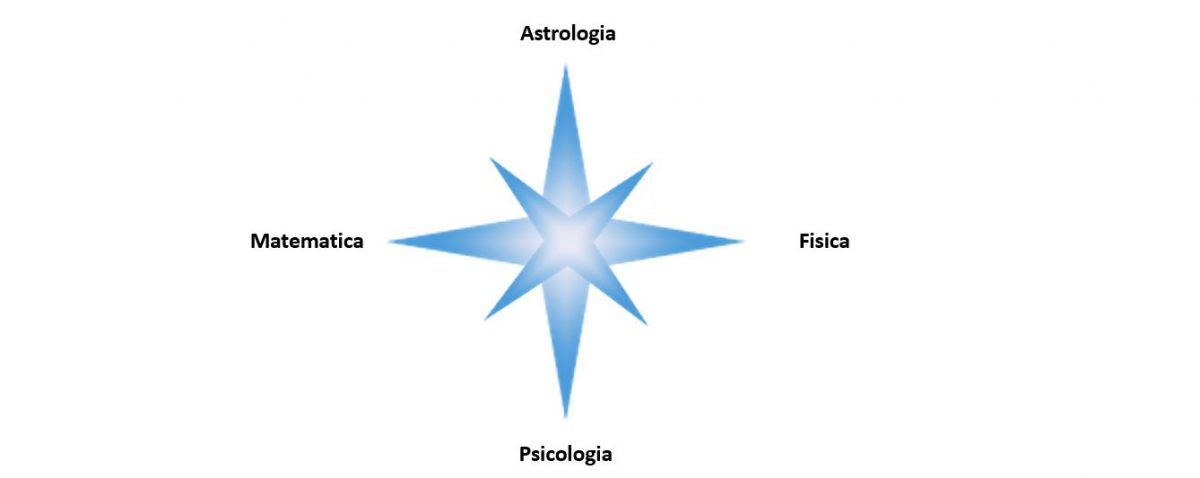Il recente episodio di chiusure generalizzate e prolungate per due giorni a causa dell’allerta pioggia non poteva non richiamare alla memoria le restrizioni vissute nel biennio del Coronavirus. Premetto che non è mia intenzione alimentare polemiche né, tantomeno, ridestare ideologie inerenti a posizioni novax, provax o quant’altro. In quanto amante della psicologia sociale e interessato da sempre a dinamiche psichiche estendibili alla collettività umana, mi sto semplicemente chiedendo se il continuo stato di allerta che ci accompagna ormai da alcuni anni – con il pretesto della pandemia, del terrorismo, dei cambiamenti climatici e delle allerte meteo, delle guerre locali che possono diventare mondiali – sia motivato e fondato su presupposti reali oppure, piuttosto, artificiosamente inflazionato con il preciso intento di diffondere paranoia a livello sociale.
Di recente ho avuto modo di leggere Psicologia del Totalitarismo, libro di Mattias Desmet che segue la strada già tracciata dalla filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt, la quale denunciava, già alla fine della seconda guerra mondiale, una fede cieca e irrazionale della collettività in una sorta di “finzione scientifica”, presupposto essenziale per il controllo sulla massa e abilmente architettata dagli organi di potere attraverso i mezzi di informazione, con la giustificazione di un nemico più o meno invisibile da debellare. Dice Desmet: “Ogni volta che nella società si affaccia una nuova causa d’ansia, un’unica risposta e una sola difesa sono approntate: maggiore controllo…la mania del controllo porta nuova ansia e l’ansia porta nuova mania di controllo. Così la società si arena in un circolo vizioso che ha come inevitabile esito il totalitarismo, ossia un controllo eccessivo esercitato dall’autorità e, infine, la completa distruzione dell’integrità psichica e fisica dell’essere umano.” Il fine, in sostanza, che poi fu anche degli Stati totalitari del Novecento, sarebbe quello trasformare le persone in soggetti atomizzati non pensanti e privi di creatività, rendendole isolate dai loro simili e dalla natura ma, allo stesso tempo, più suggestionabili e controllabili.
Esiste peraltro una sostanziale differenza sul piano psicologico tra i totalitarismi dello scorso secolo e il totalitarismo attuale: mentre le dittature si basavano sulla paura fisica, che permetteva al regime di turno di imporre unilateralmente un contratto sociale, le recenti politiche totalitariste affondano le proprie radici nel processo sociale e psicologico della cosiddetta “formazione di massa”. Essa si articola sui seguenti punti:
disponibilità al sacrificio cieco degli interessi personali in favore della collettività; radicale intolleranza per le voci dissidenti; mentalità paranoicamente delatoria, che permette agli organi di controllo di indagare nel privato dei cittadini; singolare suscettibilità all’indottrinamento e alla propaganda con argomenti pseudoscientifici; pedissequa adesione ad una logica agghiacciante che supera ogni limite etico; perdita di ogni soggettività e creatività; autodistruttività che porta al crollo finale del sistema totalitario.
Affinché si realizzi una formazione di massa devono verificarsi le seguenti quattro condizioni: solitudine generalizzata; mancanza del senso della vita; senso generalizzato di frustrazione e di aggressività; diffusione latente di ansia, paura e panico. Naturalmente, per rendere fattibile tale realizzazione, c’è il bisogno di un’informazione unidirezionale e priva di voci dissidenti, la quale, da un lato, genera suggestione a livello sociale, dall’altro placa l’ansia latente generalizzata costruendo un’ampia base sociale, mentalmente gestibile e favorevole a sostenere la miglior strategia per sconfiggere il nemico invisibile.
Già Gustave Le Bon, precursore di Sigmund Freud, all’inizio del Novecento diceva che nei casi di totalitarismo l’anima individuale, nel venir assorbita dall’anima di gruppo, perde la ragione e il distanziamento critico, abbandonandosi invece a impulsi che, in circostanze ordinarie, sarebbero considerati totalmente immorali. In sostanza, l’individualismo e il razionalismo nei singoli membri della società virano improvvisamente verso lo stato, completamente opposto, del collettivismo irrazionale. Per dirla in termini nietzschiani, Dioniso rovescia in un colpo la dittatura di Apollo e prende il potere nella società.
Nella formazione di massa il movente principale è una solidarietà con il collettivo, e chi se ne astiene viene immancabilmente tacciato di mancanza di senso civico. Questa è una delle ragioni per cui anche gli argomenti più deliranti di una narrazione che la coinvolge – tipo la necessità di una mascherina da indossare all’aperto con la bora a cento all’ora e all’una di notte – non hanno alcun rilievo per la massa, la quale crede ciecamente nella narrazione ufficiale, non perché sia giusta, ma perché crea un senso di unione tra singoli individui che si sacrificano per la causa comune, rigorosamente unilaterale e ritenuta la sola perseguibile dall’informazione pseudoscientifica. In pratica è come essere allo stadio; la voce del singolo si fonde con il coro degli ultras: cosa si canti non importa, purché si canti assieme. E così, nella formazione di massa, non importa ciò che si pensi, purché lo si pensi assieme alla massa.