Quella del tempo è indubbiamente la questione metafisica più discussa e aperta, tanto affascinante quanto misteriosa. Ognuno di noi si sarà chiesto se lo scorrere del tempo ha avuto inizio in un preciso istante oppure, magari nei giorni in cui ci siamo sentiti più romantici o mistici, se può aver senso parlare di eternità. Sant’Agostino non aveva dubbi a proposito, lasciandoci per iscritto nel De civitate Dei che la creazione dell’universo avvenne attorno al 5000 avanti Cristo. Alla domanda “che cosa facesse Dio prima di creare l’universo” Agostino rispose che Dio creò anche il tempo, mentre l’ironia di Stephen Hawking avrebbe suggerito in epoca più recente che stava preparando l’inferno alle persone che fanno domande del genere.
La maggior parte dei filosofi greci credeva invece nell’eternità, e quindi che il mondo umano esistesse da sempre e continuerà sempre ad esistere. In particolare Platone, seguendo le orme di Parmenide, prese in considerazione l’idea di Forme (o Idee) atemporali ed eterne che esistono al di fuori dell’esperienza ordinaria dei sensi. Nella matematica, per esempio, il fatto che ogni numero intero maggiore di due può essere ottenuto come media aritmetica di due numeri primi, oppure che addizionando numeri dispari consecutivi otteniamo la serie dei numeri quadrati, sono realtà inconfutabili a prescindere dalla nostra esistenza e dal nostro volere. Duemila anni più tardi Kant diceva che l’ordine temporale scandito da infinite sequenze “prima-dopo” non è un aspetto del mondo da noi percepito ma semplicemente una categoria intelligibile che precede qualsiasi esperienza umana. Un secolo e mezzo più tardi ci si accorge invece che il tempo è relativo al moto, e che spostandosi a velocità comparabili a quelle della luce il tempo è più breve rispetto a quello di un soggetto che rimane fermo. Nasce il paradosso dei gemelli: il fratello che viaggia nello spazio ritornerà sulla Terra più giovane rispetto all’altro fratello. “La separazione tra passato, presente e futuro – amava dire Einstein – è solo un’illusione per quanto tenace”. La teoria della relatività generale avvalorò anche l’ipotesi del Big Bang, ovvero dell’inizio dell’universo avvenuto circa 14 miliardi di anni fa, e della cui esplosione iniziale vediamo ancor oggi i raggi a microonde del “lampo di luce primordiale” che si espandono uniformemente in tutte le direzioni dello spazio.
Una delle tematiche più dibattute nella fisica moderna, e non solo nella metafisica, è quella che gli addetti ai lavori chiamano freccia del tempo. Il tempo aumenta irreversibilmente, esiste cioè sempre un prima e un dopo, un passato e un futuro, oppure è concepibile per i fenomeni fisici un tempo simmetrico, che può assumere valori positivi e negativi? E’ indubbio che la nostra coscienza agisce secondo il principio “causa-effetto”, che ci dà l’impressione di un tempo che procede sempre in una direzione, da un passato-causa ben definito a un futuro-effetto incerto. La fisica degli ultimi secoli ci narra però una storia diversa, fatta di leggi fondamentali (quelle per esempio di Newton, Maxwell, Einstein, Dirac, Schrodinger) simmetriche rispetto al tempo, dove i fenomeni rimangono inalterati se sostituiamo la variabile temporale t con –t. L’unico settore della fisica in cui il tempo sembra prediligere una sola direzione è quello della termodinamica. Agli inizi dell’Ottocento Carnot e Clausius scoprivano una legge tanto semplice quanto importante, ossia che il calore passa dal caldo al freddo e mai dal freddo al caldo. Boltzmann aggiunse che tale fenomeno era dovuto ad una legge puramente probabilistico-statistica connessa col moto delle particelle. Il calore non era qualcosa di materiale ma veniva determinato indirettamente dall’agitazione microscopica delle molecole: in un tè caldo le molecole si agitano molto, in un tè freddo si agitano di meno, mentre in un tè ghiacciato le molecole sono praticamente ferme. Se una parte delle molecole è ferma, molto probabilmente verrà trascinata dal moto frenetico delle particelle di corpi più caldi, cosicchè il moto comincia ad espandersi diffusamente a tutte le molecole che si urtano tra loro. E’ solo per questo che le cose fredde si scaldano a contatto con le cose calde (e non viceversa). La sorprendente e rivoluzionaria conclusione di Boltzmann poteva estendersi alla coscienza, in quanto il cervello si scalda quando pensiamo, e quindi anche il principio causa-effetto è da ritenersi come conseguenza di una legge statistica.
Non c’è spazio allora per irriducibili idealisti e sognatori che vorrebbero credere nell’eternità? Se abbandoniamo le rigorose leggi della fisica e ci avviciniamo al mondo della psicologia, gli archetipi di Jung ci riconducono alle Idee platoniche e ad un contesto eternamente immutabile fatto di simboli, sogni, visioni, fiabe e miti. Il “c’era una volta” di Cappuccetto Rosso e Cenerentola ci ricorda non a caso che l’epoca del racconto è un “passato indistinto”, che non ha bisogno di un preciso riferimento temporale. Allo stesso modo la ripetizione negli anni di un rito (Santa Messa, festività natalizia o pasquale, matrimonio, compleanno, funerale), così come la lettura di un bel libro o l’ammirazione di una qualsiasi opera artistica, ci dà la sensazione di vivere un momento sconnesso dal quotidiano scorrere del tempo. Anche l’inconscio collettivo junghiano, che rende plausibile l’esistenza autonoma e atemporale di una “storia delle memorie” generata dall’esperienza psichica di molte generazioni passate, non può che rievocare il binomio memoria-eternità di Jorge Luis Borges. Nel suo saggio dal titolo paradossale e provocatorio, Storia dell’Eternità, la passione e il ricordo tendono all’atemporalità. “Noi racchiudiamo – dice lo scrittore argentino – le felicità di un passato in una sola immagine; i tramonti che ammiro ogni sera saranno il ricordo di un unico tramonto…senza somiglianze né ripetizioni. Il tempo, se possiamo intuire questa identità, è un’illusione (Einstein docet, nda): l’indistinzione e l’inseparabilità di un momento del suo apparente ieri e di un altro del suo apparente oggi bastano a disintegrarlo.”

Nell’antichità si usava personificare l’eternità del tempo con il dio Aion, le cui sembianze leonine erano avvolte da un serpente e dai dodici segni zodiacali. Con ciò si voleva dare forma e concretezza al tempo eterno, eonico, quell’unico istante senza possibilità di ripetizioni e di cicli, in cui solo agli déi era permesso di creare. Eraclito diceva che “Aion è un bambino che gioca e che sposta le pedine, un bambino che appartiene alla sovranità”. E forse Einstein, quando in un appassionato diverbio con Bohr sulle stranezze della fisica quantistica, affermò che “Dio non gioca a dadi con l’universo”, non si allontanava tanto dal vero. Il gioco è principio creativo per eccellenza, i bambini non si ricordano di avere fame né sentono le esortazioni delle madri quando sono totalmente immersi nei loro giochi. E’ uno stato di coscienza non contrassegnato dallo sforzo, un flusso naturale o un talento del nostro agire, uno stato di concentrazione così profondo da far perdere il senso del tempo.
Il principio creativo fu però fatale a Ludwig Boltzmann, caratterialmente instabile e nato un martedì di carnevale. La sua vita giunse a fine corso un triste 5 settembre del 1906, quando la sua genialità incompresa causò l’instabilità mentale che lo spinse ad impiccarsi a Duino, nei pressi di Trieste. Solo l’anno prima Einstein scriveva l’articolo sul moto browniano delle particelle, che da lì a poco avrebbe reso giustizia alle teorie di Boltzmann che tanto avevano osato contro il comune pensare, ma destino volle che il tempo irreversibile non maturò a sufficienza e decise in quella circostanza di tradire il suo stesso creatore.
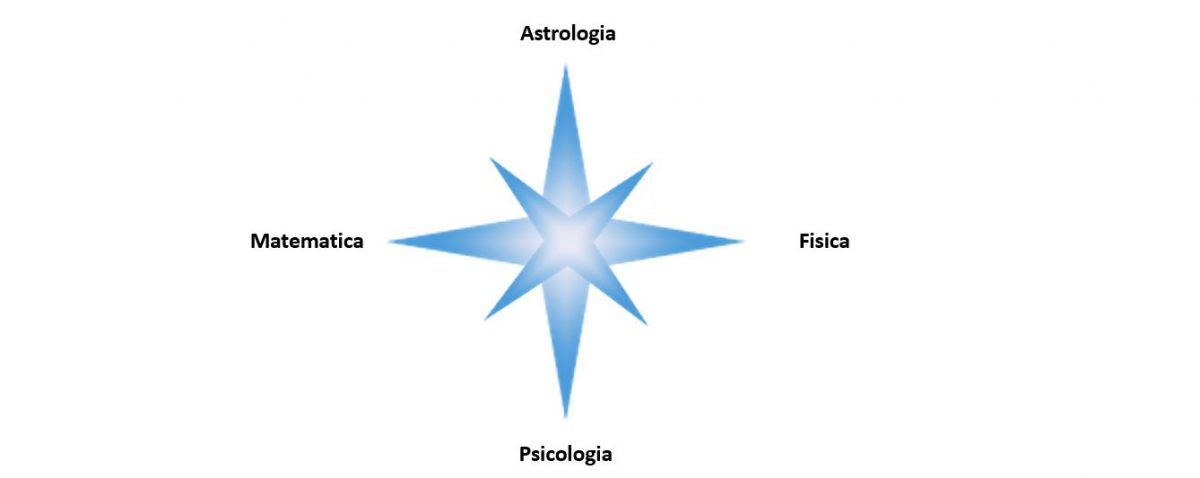




 Uno degli esempi più illustri di parricidio artistico è quello di Pablo Picasso. “En arte hay que matar el padre” confidò il pittore andaluso ad un amico quando, nell’autoritratto Yo Picasso del 1901, decise di sostituire definitivamente il cognome paterno con quello della madre. Il padre, don José Ruiz, era un modesto pittore specializzato in quadri da soggiorno in cui i piccioni apparivano come soggetto prevalente. Era anche professore alla scuola di Belle Arti a Barcellona, qualifica che mascherava un fallimento artistico messo ancor più in evidenza dal talento smisurato del figlio. Non deve pertanto stupire l’abbandono della prestigiosa Accademia Reale di Madrid, nella quale Pablo venne iscritto con l’ausilio finanziario dello zio don Salvador Ruiz, medico di Malaga e orgoglioso di dare lustro a quel cognome di famiglia che solo qualche anno dopo il nipote avrebbe rinnegato.
Uno degli esempi più illustri di parricidio artistico è quello di Pablo Picasso. “En arte hay que matar el padre” confidò il pittore andaluso ad un amico quando, nell’autoritratto Yo Picasso del 1901, decise di sostituire definitivamente il cognome paterno con quello della madre. Il padre, don José Ruiz, era un modesto pittore specializzato in quadri da soggiorno in cui i piccioni apparivano come soggetto prevalente. Era anche professore alla scuola di Belle Arti a Barcellona, qualifica che mascherava un fallimento artistico messo ancor più in evidenza dal talento smisurato del figlio. Non deve pertanto stupire l’abbandono della prestigiosa Accademia Reale di Madrid, nella quale Pablo venne iscritto con l’ausilio finanziario dello zio don Salvador Ruiz, medico di Malaga e orgoglioso di dare lustro a quel cognome di famiglia che solo qualche anno dopo il nipote avrebbe rinnegato. Canone cancrizzante è un’opera di Escher, famoso grafico e incisore olandese, il cui stile inconfondibile era quello di raffigurare nel medesimo contesto prospettive surreali e contrastanti (scale e cascate che sembrano scendere ma anche salire, figure che si compenetrano con i loro sfondi, ecc..). Il granchio di Escher avanza e indietreggia allo stesso tempo, cosa che ci ricorda lo strano e goffo andamento del crostaceo in natura. Il titolo dell’opera si ricollega al canone cancrizzante (o inverso) di Bach nell’Offerta Musicale, in cui il tema può essere letto da capo a fine o viceversa, come se si riflettesse allo specchio.
Canone cancrizzante è un’opera di Escher, famoso grafico e incisore olandese, il cui stile inconfondibile era quello di raffigurare nel medesimo contesto prospettive surreali e contrastanti (scale e cascate che sembrano scendere ma anche salire, figure che si compenetrano con i loro sfondi, ecc..). Il granchio di Escher avanza e indietreggia allo stesso tempo, cosa che ci ricorda lo strano e goffo andamento del crostaceo in natura. Il titolo dell’opera si ricollega al canone cancrizzante (o inverso) di Bach nell’Offerta Musicale, in cui il tema può essere letto da capo a fine o viceversa, come se si riflettesse allo specchio.
 Questa ambiguità tra avanzamento e indietreggiamento è una delle principali caratteristiche del quarto segno dello zodiaco, il Cancro. Potremmo anche definirla come tendenza alla regressione vitale, e nessuno più dei nativi di questo segno è sedotto da quello che in psicologia è noto come richiamo dell’utero materno, che nell’infanzia si trasforma in legami fusionali con la madre e più tardi negli anni diventa complesso materno più o meno accentuato. “Cerca la madre, troverai il Cancro” (o viceversa) potrebbe essere la sintesi estrema per definire questo segno. Regressione all’utero significa in pratica “vivere molto di più il passato che il presente”. Ricordi, nostalgie, relazioni idealizzate e poi vanamente inseguite, legami a schemi familiari, compulsività verso il cibo e ogni bisogno primario (surrogati del seno materno), ecco il mondo dei Cancro, popolato dai fantasmi dell’infanzia e dell’adolescenza, quando l’amore incondizionato della madre era l’unico insostituibile e non poteva essere messo in discussione. Non solo il passato, ma anche il futuro può condizionare e deformare la vita di questi esseri così teneri e sensibili. L’immaginato, l’irreale (o surreale), le fantasie, i voli pindarici, i sogni (un altro motto potrebbe essere “sognerà la sua vita se non può vivere il suo sogno”), insomma tutto pur di evitare la rude e prevedibile realtà o il noioso tran tran della quotidianità.
Questa ambiguità tra avanzamento e indietreggiamento è una delle principali caratteristiche del quarto segno dello zodiaco, il Cancro. Potremmo anche definirla come tendenza alla regressione vitale, e nessuno più dei nativi di questo segno è sedotto da quello che in psicologia è noto come richiamo dell’utero materno, che nell’infanzia si trasforma in legami fusionali con la madre e più tardi negli anni diventa complesso materno più o meno accentuato. “Cerca la madre, troverai il Cancro” (o viceversa) potrebbe essere la sintesi estrema per definire questo segno. Regressione all’utero significa in pratica “vivere molto di più il passato che il presente”. Ricordi, nostalgie, relazioni idealizzate e poi vanamente inseguite, legami a schemi familiari, compulsività verso il cibo e ogni bisogno primario (surrogati del seno materno), ecco il mondo dei Cancro, popolato dai fantasmi dell’infanzia e dell’adolescenza, quando l’amore incondizionato della madre era l’unico insostituibile e non poteva essere messo in discussione. Non solo il passato, ma anche il futuro può condizionare e deformare la vita di questi esseri così teneri e sensibili. L’immaginato, l’irreale (o surreale), le fantasie, i voli pindarici, i sogni (un altro motto potrebbe essere “sognerà la sua vita se non può vivere il suo sogno”), insomma tutto pur di evitare la rude e prevedibile realtà o il noioso tran tran della quotidianità.
